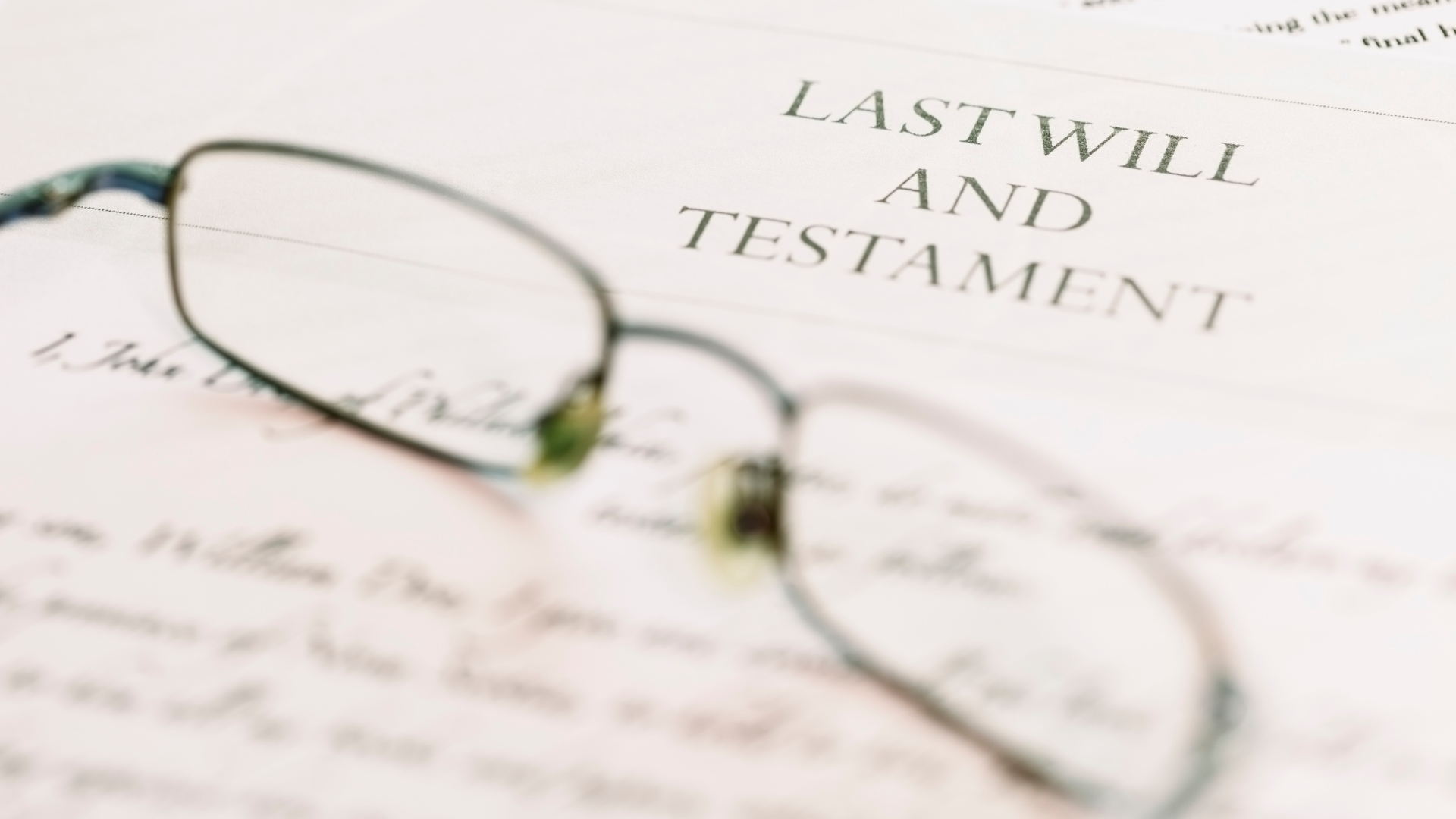
Le successioni mortis causa in generale
A cura di Dott.ssa Veronica Riggi
La successione si apre al momento della morte e nel luogo dell'ultimo domicilio del defunto, ai sensi dell'Art. 456 c. c.
Una volta aperta la successione è necessario individuare soggetti a cui il patrimonio ereditario deve essere devoluto e, a tal fine, occorre distinguere tra vocazione e delazione.
Con il termine vocazione si indica la chiamata all'eredità e cioè l'individuazione del soggetto chiamato a succedere. Tale designazione può venire attraverso il testamento con la successione testamentaria ovvero attraverso la legge con la successione legittima.
I due tipi di vocazione e cioè la vocazione testamentaria e la vocazione legittima possono coesistere nell'ipotesi in cui il de cuius abbia disposto con il testamento soltanto relativamente a parte del suo patrimonio, tant'è che il co, 2 dell'art. 457 c. c. prevede espressamente che non si fa luogo alla successione legittima se non quando manca in tutto o in parte la successione testamentaria.
Con il termine delazione, invece, si indica l'attribuzione del diritto a succedere e cioè l'offerta al chiamato del patrimonio ereditario. Con essa, il soggetto chiamato all'eredità ha una possibilità concreta di acquistare l'eredità, accettandola.
Vocazione e delazione operano in maniera simultanea e coincidono nello stesso soggetto ma, potrebbe anche capitare che la relazione non sia attuale e qui si parla di delazione condizionata che avviene in caso di istituzione di un erede sotto condizione sospensiva, in caso di istituzione di nascituri e in caso del sostituto nella sostituzione ordinaria.
Orbene, nell'ipotesi in cui due soggetti siano chiamati all'eredità in forza di un'unica chiamata, uno dopo la morte dell'altro, si parla di delazione successiva; mentre si parla di delazione solidale nell'ipotesi in cui più soggetti siano chiamati all'eredità per l'intero, in concorso tra di loro.
Si distingue la successione legittima dalla successione testamentaria ma prima di approfondirle, mi pare doveroso fare un approfondimento sulla successione dei legittimari.
Con la locuzione successione necessaria si va a designare il complesso delle norme per effetto delle quali si riconosce ad alcune categorie di soggetti, ovvero i legittimari, una posizione successoria privilegiata, che funge da limite alla libertà del defunto di disporre per testamento.
Il nostro ordinamento, pur riconoscendo la libertà al singolo di disporre del testamento dei suoi beni per il tempo in cui avrà cessato di vivere, riconosce necessariamente alcune categorie di soggetti successivi aventi diritto a ricevere una quota del patrimonio del de cuius.
I legittimari sono elencati nell'art. 536 c. c. e sono:
- il coniuge, a cui è riservata una quota che varia in funzione della presenza o meno di discendenti o di ascendenti. Ad alcuni è riconosciuto a titolo di legato ex lege, il diritto di uso e di abitazione della residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano; mentre il coniuge separato ha gli stessi diritti successori del coniuge non separato, a meno che non gli sia stata addebitata la separazione, giacchè in questo caso esso ha diritto solo ad un assegno vitalizio se al momento dell'apertura della successione godeva degli alimenti a carico del coniuge deceduto;
- la parte dell'unione civile ha gli stessi diritti del coniuge, anche se, non è ipotizzabile una condizione equivalente a quella del coniuge separato dal momento che per le unioni civili non è previsto l'istituto della separazione;
- i figli hanno una quota di riserva loro spettante che varia in base al loro numero e al concorso o meno con il coniuge con la parte dell'unione civile;
- gli ascendenti vengono presi in considerazione se chi muore non lascia figli o loro discendenti.
Detto questo, passiamo adesso alla successione legittima…
La successione legittima è la successione che opera per volontà della legge ed interviene solo quando manca in tutto in parte la successione testamentaria.
Il nostro codice civile stabilisce quali sono i soggetti chiamati a assumere la qualità di eredi cd. successibili ad assumere le quote di partecipazione del patrimonio ereditario.
Successori legittimi sono:
- il coniuge o la parte dell'Unione civile;
- i discendenti, anche adottivi;
- gli ascendenti;
- I collaterali;
- gli altri parenti fino al sesto grado.
In mancanza di tali soggetti l'eredità è devoluta allo Stato.
Il coniuge o la parte dell'unione civile ha diritto all'intera eredità se non concorre con altri successivi o alla metà se concorre con un solo figlio, ad un terzo se concorre alla successione con più figli e ai due terzi dell'eredità se concorre con ascendenti o con fratelli e sorelle del de cuius. In caso di separazione il coniuge ha gli stessi diritti del coniuge non separato, a meno che non gli sia stata addebitata la separazione, in questo caso avrà diritto solo ad un assegno vitalizio se al momento dell'apertura della successione godeva degli alimenti a carico del coniuge deceduto; il coniuge o la parte civile divorziata non ha diritto di partecipare, invece, alla successione dell'ex coniuge o dell'ex parte dell'unione civile ma, ai sensi della L. 898/1970, gli si attribuisce il diritto ad un assegno periodico a carico dell'eredità nell'ipotesi in cui si trova in uno stato di bisogno e godesse dell'assegno divorzile al momento dell'apertura della successione.
Per quanto riguarda la successione dei parenti è possibile distinguere diversi ordini:
Abbiamo detto che in mancanza di tali soggetti l'eredità è devoluta allo Stato, ciò avviene automaticamente e comporta una responsabilità per i debiti ereditari limitata al valore dell'attivo dell'eredità.
Passiamo adesso alla successione testamentaria…
La successione testamentaria è la successione regolata dalla volontà del de cuius che, attraverso il testamento, individua i soggetti a cui attribuire il proprio patrimonio e regola la distribuzione dello stesso tra i soggetti designati.
I presupposti essenziali della successione testamentaria sono l'esistenza di un testamento valido, la capacità del testatore di disporre e la capacità di ricevere per testamento dei beneficiari.
La capacità di disporre per testamento spetta a tutti i soggetti maggiorenni e capaci ai sensi dell'art. 591 c. c. che nega la capacità di testare ai minorenni, agli interdetti giudiziari per infermità di mente e a coloro che si sono trovati in uno stato di incapacità anche temporaneo. In questo caso il testamento potrebbe essere impugnato da chiunque vi abbia interesse e nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata data esecuzione alle disposizioni testamentarie.
La capacità di ricevere per testamento invece, indica le idoneità del chiamato ad essere beneficiario delle disposizioni testamentarie. Essa spetta a tutti i soggetti che siano capaci di succedere e la capacità di ricevere per testamento risulta essere più ampia rispetto alla generica capacità di ricevere per successione in quanto, hanno la capacità di ricevere per testamento e non la capacità di ricevere generica, il concepito, il nascituro non concepito ma figlio di una persona vivente al tempo della morte del testatore e le persone giuridiche.
Ciò che caratterizza la successione testamentaria è, appunto, la presenza di un testamento.
Il testamento è un negozio giuridico con le seguenti caratteristiche:
Da ultimo, ma non per importanza, vi è anche la successione a titolo particolare ovvero i legati..
Il legato è una disposizione testamentaria cd. a titolo particolare con cui il testatore attribuisce al beneficiario dei diritti determinati, i quali non vengono considerati come una quota del patrimonio ereditario. Il legato è disposto con testamento, ma può anche derivare dalla legge. Il beneficiario del legato è detto legatario mentre il soggetto su cui grava l'adempimento del legato è detto onerato.
